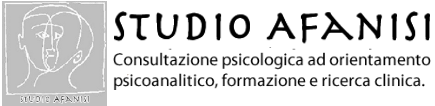Paure generalizzate o angoscia del soggetto?
La contemporaneità del mondo occidentale è caratterizzata, a livello sia collettivo che individuale, da un sempre più diffuso sentimento di paura: paura dell’invasione da parte dello straniero, paura dei terrorismi che uccidono in nome di culture estranee, per non dire della più recente paura di epidemie, che possono parassitare i nostri corpi e mettere in ginocchio il nostro stile di vita… L’uomo post-moderno appare vittima di una sorta di traumatismo universalizzato, ossessionato dalla paura e dal bisogno di sicurezza, nonostante viva da quasi un secolo in una civiltà che ha estromesso guerra e lotta per la sopravvivenza dal proprio orizzonte esperienziale, spingendole fuori dei propri confini geografici.
Sul piano della clinica, a questa paura generalizzata dell’Altro, fa eco un vertiginoso aumento di nuove forme del sintomo, caratterizzate da un cortocircuito sul corpo, da un diffuso attacco al legame e da una prevalenza di acting-out. Il corpo, e la sua semeiotica, passano dunque in primo piano, così come parallelamente la psiche e l’inconscio dei pazienti dell’oggi sembrano sparire dalla scena della cura.
Questi nuovi quadri clinici interrogano il discorso scientifico, che risponde simmetricamente, ponendo al centro il corpo-macchina, e il DSM di conseguenza crea nuovi “cluster” sintomatici, disturbi accomunati dalla presenza di “deficit”: del neurosviluppo, del controllo degli impulsi, dell’attenzione, e perché no, della “mentalizzazione”… deficit da saturare, funzioni da normalizzare. Ma se qualcosa, da sempre, manca, per il soggetto, non è forse questa perdita strutturale, ciò di cui tanto la scienza quanto il soggetto contemporaneo vorrebbero fare a meno, per sostituirla, appunto, con dei “deficit” funzionali, oggettivabili, che, come afferma Zizek, de-responsabilizzano il curante ed il paziente, “generando un immediato sollievo”?
Che relazione c’è fra la paura generalizzata dell’uomo contemporaneo – sempre più vittima di questi nuovi “traumatismi globali” – e l’angoscia del soggetto, segno di una mancanza strutturale che appare sempre meno tollerabile e simbolizzabile (J. Lacan, Sem. X) e che per questo oggi si traduce in una sintomatologia centrata sul reale del corpo? In che modo, ad esempio, il concetto freudiano di pulsione di morte può aiutarci a dar conto della ripetitività e resistenza alla cura di certe manifestazioni cliniche?
Corpo, paura, angoscia, trauma… significanti della contemporaneità, si pongono dunque al centro dell’interesse del discorso tecno-scientifico, ma anche di quello dello psicoanalista, che, specie quando opera in istituzione, deve porsi la questione se tentare di integrare le ipotesi delle neuroscienze nella propria teoria e pratica, o se ritenere l’ibridazione della psicoanalisi in un campo scientifico oggettivante, al contrario, foriera di potenziali, ulteriori impasses… Certo, i paradigmi di riferimento paiono profondamente distanti. Per la psicoanalisi l’essere umano non coincide con il corpo naturale, biologico, ma è corpo parlato, segnato dal linguaggio sin da subito: di fronte all’uomo “neuronale” delle tecnoscienze, corpo-oggetto trattato in una logica universalizzante, essa non può che rispondere con una clinica dell’uno-per-uno, proponendo una cura basata sulla soggettività, in cui fare “buon uso” dell’angoscia del parlessere e includere, nel transfert, anche l’intrattabile del godimento reale del corpo.